Da alcuni mesi parliamo di Futuro, partendo dall’idea che il futuro, in fondo, sia già oggi. Abbiamo scelto tre temi che ci sembravano particolarmente rilevanti per le organizzazioni con cui lavoriamo e che, inevitabilmente, toccano anche la vita sociale e politica di ciascuna e ciascuno di noi.
Siamo partite e partiti con la glaciazione demografica, dedicandole tre mesi di esplorazione, passando attraverso il testo di Alessandro Rosina e una riflessione di Ugo Morelli sul desiderio, nel tentativo di allargare lo sguardo oltre i ciò che ci dicono i numeri (lo trovi qui).
Ora siamo nel cuore di un altro nodo: quello della polarizzazione. E da qui vorremmo continuare il nostro percorso, che ci porterà, infine, a parlare di futuri possibili.
Per attraversare il tema della polarizzazione, ci sembrava importante includere uno sguardo diverso, capace di spostare il focus, di disturbare gentilmente l’ovvio. Abbiamo allora pensato a Fabrizio Acanfora, convinte che le sue riflessioni potessero arricchire le nostre domande e aprire nuove traiettorie.
Fabrizio Acanfora è autore, musicista e divulgatore noto per il suo lavoro sui temi della neurodivergenza, della diversità e dell’inclusione. Il suo ultimo libro, Rompere il gioco. L’attivismo nel Ventunesimo secolo (Effequ, 2025), è un invito a ripensare le regole implicite che governano le nostre vite, mettendo in discussione i meccanismi di normalizzazione, appartenenza e marginalizzazione.
A lui abbiamo chiesto se – e come – la polarizzazione sia un sintomo dei nostri modi di organizzare la realtà. Da dove viene, come viene coltivata, e in che modo influenza (e viene influenzata da) il nostro modo di leggere e pensare il mondo, dentro e fuori i contesti a cui apparteniamo.
Qui sotto riportiamo la trascrizione delle sue parole.
Abbiamo cercato di restare il più possibile fedeli all’emersione viva di questa conversazione.
L’abbiamo divisa in paragrafi più brevi, per facilitarne la lettura.
Il futuro, che è già qui
Mi piace molto il tema del futuro, del futuro che è già qui. Sarei voluto tornare alla narrativa, magari scrivendo un libro distopico; ma alla fine penso che ne sarebbe uscito un saggio sull’attualità, perché siamo piombati nella peggiore distopia che potessimo immaginare.
Per quanto riguarda la polarizzazione – che forse prepara il terreno al modo in cui stiamo vivendo il futuro – partirei da ciò che è insito in noi: la necessità di separare, categorizzare.
Ci sono tante evidenze che ci fanno riflettere su quanto si tratti di un meccanismo insito nel nostro funzionamento, sociale e personale.
Credo possa essere interessante partire da tutti quegli studi che si riferiscono ai gruppi – tra cui gli studi di Tajfel – che analizzano i nostri meccanismi di relazione con chi consideriamo esterno al nostro gruppo e il processo di costruzione dell’alterità. Anche quando facciamo riferimento al Vangelo, diciamo spesso “ama il tuo prossimo”, ma va ricordato che, nei tempi a cui fanno riferimento quei testi, il “prossimo” era inteso soprattutto come il simile, il membro della propria comunità – non tanto l’altro o il diverso, come lo intendiamo noi oggi.
Polarizzazione: tra natura e tecnologia
Questa idea di clan è estremamente complessa oggi, perché siamo tutti connessi. Credo che il problema non stia nella dinamica in sé, che è insita nel nostro modo di vedere la realtà: abbiamo la necessità di categorizzare per farci un’idea della realtà. Ma è nel momento in cui categorizziamo, che qualcosa entra dentro una categoria e qualcosa ne resta fuori. È facilissimo, allora, trovare il “contrario” e iniziare a discutere, anche in maniera molto accesa.
Il problema sono i mezzi che abbiamo oggi, che sono mezzi immediati, proprio nel senso del termine: non mediati. Abbiamo accesso diretto a informazioni che arrivano da tutto il mondo, a volte non verificate, non controllate. Ci troviamo in situazioni che hanno generato, amplificato dinamiche che abbiamo sempre più o meno vissuto. Ci circondiamo di persone con le quali abbiamo qualcosa in comune, che condividono le nostre idee. Ma le echo chambers sono diventate estremamente preoccupanti.
Io non credo che il digitale sia neutro. Anzi: gli strumenti digitali sono stati disegnati per ottenere risultati precisi e, intenzionale o no, la polarizzazione delle opinioni ne è una conseguenza importante. Perché? Perché se il tuo obiettivo è ottenere un profitto economico tenendo più tempo possibile le persone su una piattaforma, cercherai di generare interazioni che accrescano l’interesse; e questo non si ottiene facendoci i complimenti o dicendoci che ci vogliamo bene. Se io commento sotto il post di qualcuno scrivendo “ah bravo, complimenti”, l’altra persona mi risponde “ah che bello, grazie”, l’interazione si chiude. Se invece dico che “quello che hai scritto mi fa schifo” – magari aggiungendo un attacco personale e non una critica nel merito, perché funziona meglio – riceverò una reazione imbestialita e da lì cominceremo a litigare. Poi arriveranno altre persone a dare supporto all’una e all’altra fazione. Questo è un modo facilissimo per generare profitto per chi possiede questi strumenti: oltre a farci produrre gratuitamente contenuti per la piattaforma, si massimizza il tempo che ci trascorriamo sopra e in cui produciamo dati e vediamo pubblicità.
Credo che siano i mezzi che oggi utilizziamo per comunicare a rendere la polarizzazione inevitabile e anche estremamente radicata, cristallizzata nelle relazioni. Spesso, nella vita digitale, persone che fuori sembrano estremamente tranquille e ragionevoli hanno reazioni estreme. E non mi riferisco solo ai social media, ma anche alle applicazioni di messaggistica, che permettono di mandare i peggiori messaggi senza mai avere una persona davanti. Questa amplificazione è stata volontaria, attraverso strumenti creati con intenzione precisa di ottenere determinati effetti.

Parole, etichette
Alcune parole sono già polarizzate, cioè segnate da interpretazioni opposte e spesso inconciliabili. Basta nominarle per generare reazioni immediate, spesso viscerali. Prendiamo la parola “inclusione”.: Ogni volta che ho criticato questo concetto mi sono arrivate valanghe di critiche. Una delle più frequenti è l’accusa di ingratitudine: “ma come? se non accetti l’inclusione (che, tra l’altro, tipicamente viene benevolmente calata dall’alto in modo paternalistico) allora non ti sta bene niente. È una reazione tipica di chi esercita il potere di escludere, e poi di includere, senza mai interrogarsi sul privilegio che gli consente di farlo.
Ma anche solo nominare parole come “privilegio” è sufficiente a innescare la polarizzazione; Perché chi gode di un privilegio spesso non se ne rende conto, e sentirlo nominare genera disagio, difensiva, colpa. È un meccanismo ben noto: la persona si sente chiamata in causa, messa sotto accusa, anche se il discorso è strutturale e non personale.
Lo stesso avviene con le etichette. Le persone che più spesso mi hanno chiesto “Ma perché etichettare tutto?” sono le stesse che mi hanno etichettato in una categoria clinica, in un gruppo sociale. Etichettano per poterti studiare. Nella sociologia dell’inavvertito, si fa notare una cosa semplice ma fondamentale: la normalità non ha nome. Ciò che studiamo viene nominato, e quindi si distingue. Ciò che non ha nome è dato per scontato, e proprio per questo diventa una sorta di privilegio: non serve difenderlo, giustificarlo.
Le categorie – come le parole “inclusione” o “privilegio” – funzionano nello stesso modo: sono strumenti di distinzione. E la critica alle cosiddette politiche identitarie – che pure, va riconosciuto, hanno dei limiti – arriva spesso da una destra che, paradossalmente, fa ampio uso della propria identità come strumento di definizione. È così che funziona il privilegio: ti permette di non vedere la tua posizione come identitaria, ma solo come universale, neutra, naturale.
Normalità, inclusione e privilegio
Anche parlare di “normalità” è estremamente polarizzante. Basti vedere l’uso che, per esempio, Vannacci ha fatto di questo termine nel suo libro: un uso funzionale al potere. Le persone che si considerano normali vivono questa definizione in modo positivo e la associano a un’idea di naturalezza: normale è interpretato come naturale. Ma la normalità è una media statistica: un modello ideale che, di fatto, nessuno incarna davvero. È una costruzione sociale, non una condizione naturale..
Ed è proprio su questo fraintendimento che si innesta la polarizzazione: quando idee diverse vengono esasperate e la discussione si appiattisce. Dove c’è complessità difficilmente ci sono solo due poli opposti; dove c’è la capacità di cogliere la complessità delle cose, si è sempre meno tendenti a condannare senza appello l’avversario.
Mi è stato spesso detto che “alla fine giustifico tutti”. Io non giustifico e non amo farlo; però provo a comprendere che cosa ci sia dietro a certi comportamenti o idee. E credo che questa attitudine non porti necessariamente a essere indulgenti, anzi, a volte i giudizi possono essere anche molto severi. La differenza, però, sta proprio qui: c’è una grande distanza tra il dire “no, questo non va bene” dopo aver considerato con cura la complessità della situazione – lasciandosi magari anche un margine di dubbio – e, invece, il semplificare tutto, riducendo la realtà a un aut-aut.. Quando si ragiona solo per opposti – se tu pensi A e io penso B, allora uno dei due deve avere torto – si finisce, nei casi più estremi, col “cancellare” l’altro, anche dal discorso pubblico. Basti pensare, per esempio, a ciò che è successo negli Stati Uniti durante l’amministrazione Trump: alcune parole o definizioni sono state eliminate dal lessico ufficiale. La cancellazione è proprio una delle conseguenze della polarizzazione: è una figlia diretta della semplificazione.
Identità e neoliberismo
Sappiamo che situazioni simili sono già accadute in passato. Ma adesso ciò che preoccupa non è solo la velocità con cui accadono le cose (la velocità, di per sé, potrebbe anche non essere negativa: ciò che nasce in fretta può crollare altrettanto rapidamente), ma il fatto che vengono utilizzati strumenti privati e che questi siano in mano a personaggi che li sfruttano per portare avanti le loro idee politiche e personali, oltre che il loro business. Continuando a comunicare attraverso questi canali, finiremo per rimanere incastrati in questa situazione.
Il neoliberismo ha contribuito a tutto ciò in un modo interessante. All’inizio poteva sembrare che favorisse la complessità sociale: negli ultimi decenni, infatti, è emerso un grande pluralismo di identità e appartenenze. Tuttavia, questo processo non è stato necessariamente un obiettivo esplicito delle politiche neoliberiste, quanto piuttosto una delle conseguenze – spesso inattese – dei cambiamenti economici e culturali degli ultimi decenni.
Se pensiamo poi al pensiero di filosofi come Foucault, possiamo notare come le sue riflessioni critiche sull’individualizzazione e sulla libertà abbiano descritto alcuni dei processi che si sono poi sviluppati nell’epoca neoliberista, soprattutto in relazione al concetto di libertà dei mercati. Il concetto stesso di libertà oggi è il risultato di dinamiche di individualizzazione che, in parte, trovano origine nell’economia politica di Adam Smith e nel capitalismo industriale che ha contribuito anche alla nascita della democrazia liberale in Occidente. Ma si tratta di processi articolati, che non vanno letti come lineari
Il neoliberismo nasce come reazione delle élite economiche al modello interventista del New Deal, nato per affrontare la Grande Depressione; il timore di uno stato che interviene per porre dei limiti a un capitalismo fuori controllo. Dagli anni Ottanta è stata applicata alla politica e all’economia la dottrina neoliberista, costruita a partire dagli anni Trenta. E la nuova narrazione è stata diffusa lentamente dagli anni Cinquanta grazie i think tank, che hanno prodotto studi economici, influenzato i media, le università, i governi. C’è stata la capacità – la pazienza, soprattutto – di creare questa narrazione che doveva riuscire a convincere le persone (la massa, il popolo, la classe lavoratrice) della bontà di tutta una serie di misure che andavano apertamente contro di loro. È stato eroso il diritto a una rappresentanza sindacale, alle pensioni, alla sanità; però questa sottrazione è stata proposta come progresso. Il lavoro è diventato precario, ma questa precarietà è stata definita “flessibilità”.
È il periodo dell’auto imprenditorialità, una spirale in cui la competizione viene pompata sotto steroidi e l’individualizzazione è diventata il principio regolatore della società. Nel liberalismo classico era la libertà il valore centrale (il laissez faire), non la competizione. È con il neoliberismo che la competizione viene trasformata in necessità costante, spacciata per naturale ed estesa a ogni ambito della vita: così si costruisce una narrativa che ci chiede di gareggiare sempre, anche dove non sarebbe necessario.
La normalità è diventata frattale
Nel libro L’Errore spiego che il concetto di normalità, per come lo intendiamo oggi, nasce con il capitalismo industriale: serve come strumento di controllo sociale, di standardizzazione e di divisione attraverso la statistica, la scuola, la medicina, la disciplina degli orari. Col neoliberismo questa normalità non scompare, ma si frammenta, si polverizza: diventa “frattale”, moltiplicandosi in tante micro-normalità all’interno dei gruppi e delle categorie.
Ogni categoria funziona come una piccola normalità interna e in tutte le categorie vigono le regole della normalizzazione. Prendiamo la categoria LGBTQ+ (in cui anche io rientro): in ogni lettera c’è un ‘identità distinta. Questa categoria, esclusa arbitrariamente dalla normalità, funziona come una piccola normalità a sua volta, in cui per essere ammessa o ammesso, devi soddisfare determinati criteri. Questo meccanismo, che vale per tutte le categorie, contribuisce a generare un discorso di un individualismo assoluto, che è stato probabilmente il trucco fondamentale per cuinon siamo più in grado di reagire come società, di intraprendere battaglie collettive così come invece accadeva alcuni decenni fa. È la creazione di guerre tra poveri.
L’apparente immobilità di oggi non è una questione di passività, ma è la conseguenza di dinamiche profonde che hanno disinnescato la capacità di risposta collettiva: in questa logica, perfino di fronte a eventi drammatici come il genocidio a Gaza, spesso ci limitiamo a reazioni minime e simboliche, non rendendoci conto che questa assuefazione prepara il terreno a scenari ancora più problematici.
Il neoliberismo ha giocato un ruolo centrale nella trasformazione dei processi di normalizzazione. Mentre il capitalismo industriale puntava su una normalità unificante, oggi ci troviamo in una società che tende a individualizzare fortemente le persone. Questo non significa che l’identità sia semplicemente “più forte”, ma che ognuno è sollecitato a costruirsi la propria, spesso cercando appartenenza in gruppi e categorie sempre più specifici.
In questo scenario si produce un paradosso: la proliferazione di micro-gruppi o micro-appartenenze, ciascuna con le proprie regole di normalizzazione interna, genera nuove forme di inclusione ed esclusione. Ian Hacking parlava di “looping effect”: le categorie nate per descrivere persone o gruppi – pensiamo, ad esempio, all’omosessualità o all’autismo – influenzano il modo in cui le persone si percepiscono e vengono percepite e le esperienze individuali, a loro volta, modificano e ridefiniscono la stessa categoria sociale.
Ciò porta a una dinamica circolare: le categorie servono sia a includere sia a distinguere, e finiscono per creare nuovi criteri di “normalità” anche all’interno di gruppi originariamente marginalizzati o nati per opporsi alle norme dominanti. Questo contribuisce sia alla ricerca di riconoscimento, sia alla moltiplicazione dei confini fra le identità.
Credo che sia essenziale riconoscere e valorizzare l’identità di ciascuna persona. Il problema è che l’attenzione all’identità si sviluppa in un sistema che tende a mercificare qualsiasi cosa, paradossalmente anche l’identità stessa.
Come possiamo fare a conciliare l’aspetto identitario con quello politico e sociale? È importante che le persone possano riconoscersi nella loro identità senza tralasciare la dimensione collettiva, recuperando la questione di classe, ancora di più in un momento così delicato, in cui il sistema mostra di funzionare come una macchina perfetta.
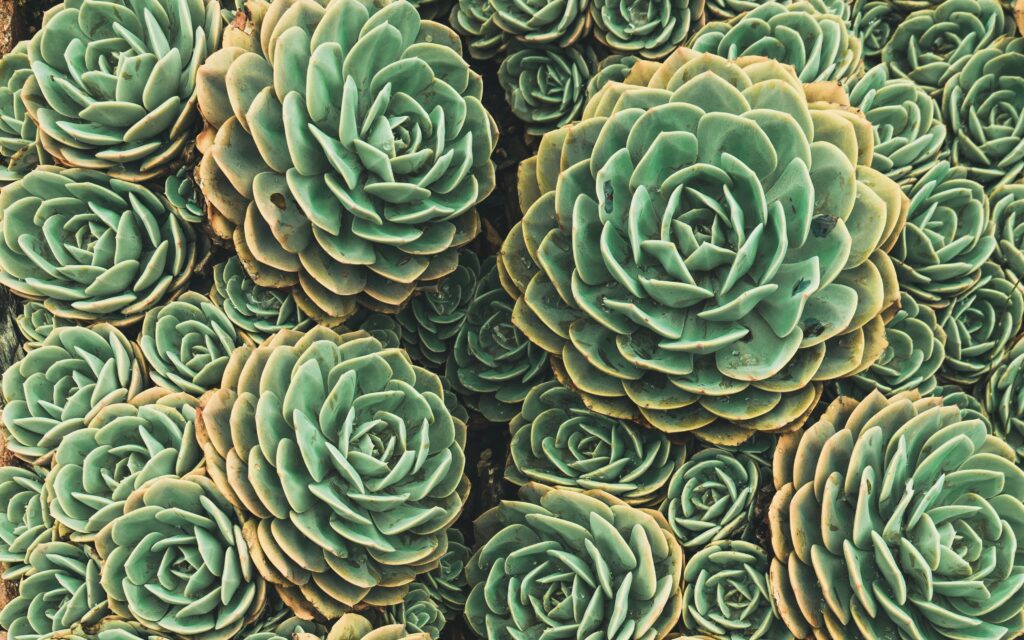
Complessità, speranze, futuri
Credo che alcune parole possano aiutarci a riflettere su dove siamo e su cosa possiamo fare. La prima è complessità. Dovremmo forse prendere atto che la vita – individuale e collettiva – è fatta di molti livelli intrecciati, di elementi che interagiscono tra loro. Semplificare troppo è sempre rischioso e porta fuori strada.
In questi anni, pur nella piena consapevolezza che viviamo in una società profondamente diversa rispetto a quella degli anni Venti del secolo scorso (con strumenti, tecnologie e dinamiche politiche e sociali del tutto nuove) credo che alcune tensioni e situazioni presentino analogie con quel periodo. Naturalmente il contesto è cambiato radicalmente ma noto come, in forme nuove, riaffiorino polarizzazione, incertezze collettive e processi di esclusione che ricordano, almeno a livello strutturale, quelli già vissuti allora. È importante sottolineare che non si tratta di ripetizioni automatiche né di semplici analogie, ma di parallelismi che meritano attenzione, sempre con la consapevolezza della complessità attuale.
Vale la pena ricordarci che quando si raggiungono livelli di semplificazione e di polarizzazione tanto elevati, per cui la parte che riesce a esercitare maggiore potere schiaccia sempre di più l’altra, si arriva sempre a una reazione violenta. E più reprimi, più violenta sarà la reazione. A me, questo fa paura: il non renderci conto che se guardassimo non soltanto quello che è successo poco tempo fa, ma anche più indietro, scopriremmo che quando il potere incomincia a concentrarsi in gruppi sempre più ristretti, poi avvengono determinate cose.
È vero che oggi siamo sempre più individualizzati, atomizzati, che viviamo in una società che ha persino superato quella che Bauman definiva modernità “liquida”. Ormai siamo a uno stadio gassoso dove tutto è volatile e sfuggente, dalle relazioni alle appartenenze collettive. Ma quando questa società, sotto pressione, viene spinta a tornare a una normalità solida, a forme rigide di ordine e valori, ciò che era disperso e frammentato rischia di ricompattarsi di colpo, e questa ricomposizione esplosiva può diventare fonte di grandi tensioni, conflitti e polarizzazione estrema.
L’ultima statistica diceva che il 57 % degli americani è contrario alle politiche migratorie di Trump; quanti immigrati hanno votato Trump e poi si sono visti deportare familiari? Quante aziende, quanta parte del mercato aveva votato Trump e adesso rischia di ritrovarsi senza mano d’opera?
Tutte queste cose hanno già il germe della reazione. Questo è preoccupante, ma mette anche po’ di speranza.
Io spero che potremo arrivare prima a una soluzione, che le persone si rendano conto realmente del rischio a cui ancora possiamo sottrarci, proprio iniziando a organizzarsi di più, nella realtà, a pretendere che il potere, oltre alla ricchezza, venga redistribuito. . Abbiamo a disposizione strumenti per evitare la catastrofe, se vogliamo. Ma dovremmo iniziare a usarli, insieme, come collettività.
Proteine
Abbiamo selezionato alcune proteine legate al tema delle polarizzazioni, per allargare lo sguardo. Le trovi qui.
Immagine di copertina Fujiwara; nel testo, a partire dall’alto: Kumiko Shimizu e Sergio Medina – @Unsplash

